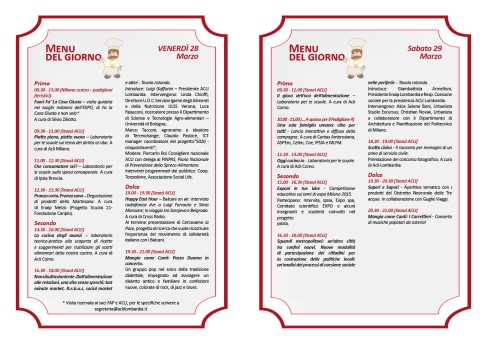Vent’anni.
Nella storia del mondo sono una briciola infinitesimale, ma nella vita di una persona (relativamente) giovane, hanno un certo peso. Se 20 anni fa mi avessero chiesto cosa avrei voluto fare nella vita, non so cosa avrei risposto. So che dopo quel 1992 la linea che ho sul palmo del mano mi ha condotto dove dovevo andare. So quanto mi è costato e so quanto è costato alla mia famiglia e ai miei affetti. E so quanto ancora oggi mi e ci costa.
Vent’anni fa avevo meno di 18 anni e per me Sarajevo era un luogo non tanto lontano nel mondo, che qualche decennio prima era stato teatro dell’attentato al baffuto Francesco Ferdinando a cui poi seguì la Prima guerra mondiale. Una data da ricordare negli esami di storia.
Soltanto qualche anno dopo, nel febbraio del 97, misi piede nella città che oggi è un po’ il centro del mio mondo. Con maggiore consapevolezza che Sarajevo non era soltanto una città della ex Jugoslavia titoista, famosa per essere tra i paesi non allineati e dunque un altro dato per i famosi esami di storia, ma era un luogo simbolo della barbarie contemporanea, vittima di urbicidio, resistente nei secoli alle strane pieghe che la storia prende.
Girava e gira tuttora questa storia, che durante gli anni dell’assedio, quando le biblioteche bruciavano e i musei venivano depredati, qualcuno abbia staccato dal pavimento la lastra su cui erano impresse le orme di Gavrilo Princip, posta nel luogo da cui il rachitico studente aveva fatto per caso e per fortuna fuoco all’arciduca. Lì, dove scorre il fiume Milijacka, passò ancora molta acqua e molto sangue, nel corso degli anni a venire.
Il ricordo che ho di quella Sarajevo del 97 è un viaggio lungo, partendo con un furgone rosso da Kljuc, dove l’Organizzazione con la quale tuttora lavoro aveva in atto un progetto di ricostruzione.
A causa di un ritardo nella consegna, non avevo il passaporto, ma mi ero convinta e avevo convinto i miei compagni di viaggio che era sufficiente la carta d’identità. Negli innumerevoli posti di blocco che incontravamo si stupivano un po’ tutti, ma la logica era ferrea: se l’han fatta passare gli altri, allora va bene così…quelle ombre grigie nella burocrazia socialista ancora permettono di trovare strane scappatoie. L’unico problema con quel documento in verità l’ho avuto dalle parti di Dobrinja, dove dei poco concilianti poliziotti ci hanno fatto capire che ci conveniva toglierci di torno in fretta, prima di andare troppo a fondo nel controllo documenti.
Mi ricordo allora le torri dell’Unis sventrate (e mi ricordo che quando mi chiamarono al telefono l’11 settembre di qualche anno dopo, mi ero stupita che qualcuno avesse tirato giù di nuovo le torri di Sarajevo, sentendomi prontamente dare della rincoglionita), lo scheletro dell’Oslobodjenje, il Parlamento che crollava a pezzi, come del resto tutta la città. Le mine nei cortili a Dobrinja, le case incendiate a Grbavica, i cimiteri improvvisati, le scritte Pazi Snajper.
Poco traffico, macchine d’altri tempi, la Bascarsija sotto la pioggia. Era grigio, il tempo, ma non ho ricordo che fosse freddo, nonostante il periodo. Ero a Sarajevo, la città che dal ’92 avevo cominciato a leggere e vedere nei telegiornali e immaginare.
Oggi sono passati vent’anni. La città ha messo su il vestito della festa, per trovare tracce della guerra bisogna avere occhi abbastanza attenti specialmente in certi quartieri. E per fortuna che è così. Tutt’oggi mi viene l’orrore a vedere i tour che vengono organizzati: la Sarajevo dell’assedio, il war tour, le trincee e i campi minati. Penso che ci voglia una certa discrezione e preparazione nel visitare certi luoghi, perché è facile rimanere impressionati da quello che la guerra ha lasciato, a partire dal numero dei morti: 11.541. Penso che per rispetto di questi luoghi e di questi caduti, non sia giusto andare armati di macchine fotografiche a scattare a raffica delle immagini da mostrare agli amici al proprio ritorno. Buchi nei muri, proiettili, granate, tombe, il tunnel, le trincee, il campo minato. Non voglio peccare di presunzione, ma per me questi buchi, queste rose di granata, questo tunnel significano qualcosa. Non posso associare ogni singolo proiettile a ogni singolo evento o a ogni singolo morto, ma è quasi come fosse così. Non posso partecipare al dolore individuale di ognuno, ma posso partecipare a quello collettivo. E la parola rispetto, è l’unica che mi viene in mente, quando penso a questa città e all’intero Paese, e a quello che ha vissuto.
Per questo penso sia necessario cercare di vedere Sarajevo con occhi nuovi. La guerra fa parte di Sarajevo e l’ha segnata con cicatrici incancellabili, ma per un turista di oggi – magari un ventenne – penso sia più significativo guardarla, facendo un salto indietro nel tempo, perché per lui un cimitero, una targa commemorativa o un palazzo bruciato, nella maggioranza dei casi significa qualcosa che probabilmente ha visto solo in un film. E probabilmente non è qualcosa di impressionante. E’ quasi un souvenir, chissà. Ma facendo questo salto nel tempo si può vedere la Sarajevo che era prima del 1992 e che è oggi. Non significa cancellare un pezzo di storia, ma vederla nel suo complesso. Le terme romane, la parte turca, le fortezze e le porte della città, i palazzi austroungarici, lo stile Secessionista viennese e il moresco, il primo tram in Europa, la parte socialista nella sua bruttezza, le Olimpiadi invernali dell’84. E naturalmente la sinagoga, le moschee, la chiesa ortodossa e quella cattolica nell’arco di poche centinaia di metri, come ancora oggi con orgoglio i sarajevesi mi dicono, quando in taxi mi vogliono parlare della loro bella città. Colto questo, di questa città, allora si può capire cosa abbia significato l’assedio di oltre tre anni. L’urbicidio, termine coniato dal grande architetto e pensatore Bogdan Bogdanovic.
Oggi sorgono centri commerciali, chiudono i musei. Nei negozi della Bascarsija si vendono lampade turche e nei locali si fuma il Narghilè. Nuove mode, al passo coi turisti di oggi, ma per chi cerca dei veri angoli sarajevesi, resistono locali demodè in cui rifugiarsi.
In questi tanti anni, penso di essere stata a Sarajevo almeno 2 volte all’anno, a volte per periodi lunghi, a volte per dei week end folli. 12 ore di macchina per mangiare dei cevapi da Zeljo.
Ho dormito in tante case diverse, ho conosciuto tante persone diverse. E ne incontro ancora oggi, nei posti più impensati.
Per me questa città resta un emblema, un posto dell’anima – oltre che un posto con un’anima.
Ho girato tutta la Bosnia (ed Erzegovina, come mi rimprovera spesso un’amica mostarina) – e non solo – in questi anni, una volta ho provato a fare il conto dei Km percorsi su strade balcaniche e di quante volte ho bucato, o quante volte ho rischiato di andare sotto un camion, o di scivolare sulla neve. Se la circonferenza della terra è di circa 40.000 Km io l’ho girata già almeno 8 volte, facendo la tratta Milano – autostrada della fratellanza e dell’unità.
E nonostante i sentieri sterrati e i tanti piccoli posti visitati, se penso alla Bosnia, penso a lei, Sarajevo.
Perché era una piccola Bosnia, ma anche qualcosa di più. Un luogo di cultura, di tradizioni, di patrimonio che per me, milanese e occidentale, assomiglia di più a quello che è il mio quotidiano. Da un anno vivo a Bihac, nella Krajina occidentale, e per quanto questo posto si dia arie di città, c’è un abisso dal mio mondo. Per questo Sarajevo mi è vicina, perché trovo dei punti di contingenza. Sicuramente non architettonici, ma come flussi, come luoghi di cultura, come atteggiamenti di apertura e freddezza al tempo stesso. A Sarajevo la gente non ti fissa per strada come succede nei piccoli centri, ma se ti fermi a parlare puoi star certo che avrai attorno a te una folla di gente curiosa e pronta ad aiutarti.
Ma la Bosnia Erzegovina è una e unica, Jedna i Jedina, e sì, il 6 aprile del 92 è una delle date, ma non è l’unica da ricordare in questo Paese. Come in ogni tragedia ci sono poi dei simboli che la racchiudono tutta e come in ogni storia ci sono dei ricordi e dei momenti più significativi di altri.
E non è un caso che le prime vittime dell’assedio di Sarajevo siano state uccise durante una manifestazione per la pace, che siano donne, e che non siano di Sarajevo. Già da questo, si capisce tanto.
Parlare oggi di Sarajevo per me significa ricordare un luogo – speciale – che mi ha segnato nell’immaginario prima che nel vissuto reale, ma anche ricordare un intero contesto.
Nella primavera del ’92 le città della Bosnia orientale erano in fiamme e le persone che ho conosciuto nei campi profughi dove sono stata come volontaria venivano da lì, da Doboj, da Bijelina, da Zvornik, da Modrica. Oggi, molte delle campagne attorno a queste città, sono coltivate soltanto a rovine, case bruciate dove nessuno farà mai ritorno.
Vent’anni.
Potrei andare avanti a scrivere molte cose, di questi vent’anni. Forse un giorno raccoglierò i ricordi e i pensieri e cercherò di dargli una forma, ma non oggi, non ancora.
Potrei parlare, di come per me tutto è cominciato, ma non è lo spazio e il luogo. Come tutto sta continuando, ma anche questo non è il momento.
Posso solo dire che non pensavo, vent’anni fa, a 17 anni, di innamorarmi così tanto di una storia, di un luogo, di un popolo. Perché per me esiste un solo popolo, quello bosniaco. E sono anche stanca di tante parole spese, di tante continue polemiche ancora oggi, specialmente tra chi viene da fuori, su questo tema.
Serbo, croato, bosgnacco.
Lasciamo che siano loro a decidere come chiamarsi e scopriremo tante cose nuove sul modo in cui oggi un abitante della Bosnia Erzegovina si definisce.
Non più tardi di dieci giorni fa ho accompagnato mia sorella a fare un reportage per il settimanale per cui scrive e abbiamo intervistato 11 ragazzi e ragazze di Sarajevo e non solo, nati tutti nel 1992.
La guerra è lontana, per loro. Ed è giusto che sia così. Sono persone che vogliono immaginarsi un futuro diverso da quello dei loro genitori. Vedono la Bosnia come un luogo in cui vivere e lavorare, che ha del potenziale e che sta facendo molti progressi. Vogliono un lavoro adeguato alla loro carriera scolastica e sono stanchi delle solite spintarelle di cui molti usufruiscono. Non guardano il film di Angelina Jolie perchè per loro è troppo brutale.
La guerra è, dalle parole di una loro fuggita in Germania ai tempi dell’assedio, un’immagine dei proiettili traccianti vista in televisione e io che chiedo ai miei genitori di cambiare canale, perché quel film non mi piace.
Ecco, questa semplicità nel ricordare qualcosa di lontano, mi fa dire che oggi, vent’anni dopo, si scontrano fortemente due mondi. Leggendo le parole di molti in questi giorni, di gente di fuori, mi viene da dire: lasciamo in pace questa terra. Perché secondo me, loro non hanno bisogno di noi, ma se giro la frase, faccio una domanda: noi abbiamo bisogno di loro? Rispondo di sì.
Perché percepisco quel bisogno di adrenalina tra le righe dei giornalisti che stanno organizzando una Reunion a base di cavolo e caviale, vestiti in combat gear e/o abito scuro, all’Holiday Inn.
Un bisogno di incontrarsi e rievocare, provare, rivivere quelle sensazioni vissute ai tempi, quando i proiettili ti fischiavano vicini, quando alcuni di loro avevano i capelli ed erano più magri, quando era emozionante fare uno scatto a un moribondo con la macchina fotografica e pagare cifre spropositate per una vodka al mercato nero, da bere nello scantinato dell’albergo. Quando un’elite che poteva pagare esorcizzava la morte che gli alitava vicino, bevendo, scopando, fumando. Era emozionante sentirsi vivi.
Non voglio dire che il ruolo dei reporter di guerra sia un ruolo secondario, se non ci fossero state queste persone, difficilmente il mondo avrebbe avuto l’orrore in copertina, come vent’anni fa succedeva. Abbiamo visto i lager, le stragi, il genocidio in diretta, ai tempi. Ma sappiamo anche dei servizi falsi, delle persone messe in posa, delle notizie vendute, così come oggi sappiamo anche le cose che non ci erano state dette.
E’ che a proposito di tutto questo, oggi, vent’anni dopo, mi interrogo sullo spirito con il quale stiamo per vivere queste giornate.
E’ una giornata del ricordo, è un’occasione per fare analisi, critica, memoria. Ma anche un momento per vedere il presente e il futuro.
La fatica che vedo, nelle parole che sento e che leggo, è quella di riuscire a leggere l’oggi e pensare a un domani, senza continuare a tornare indietro. Ricordare è un diritto civile. Imparare una prerogativa di pochi.
Ho come la sensazione che ci sia quest’entusiasmo quasi morboso, oggi, in tutto questo correre a ricordarci dei vent’anni. Ma i diciannove sono stati meno importanti? E quando saranno 24 non avranno lo stesso peso? I morti muoiono solo nei multipli di dieci?
La Bosnia è stata pacifismo, volontariato, militanza, sangue, martirio, politica, interventismo, aiuti umanitari, bambini, mercato nero. Un frullato di tante diverse cose, in cui noi siamo stati allo stesso tempo attori e spettatori.
Ancora oggi non sappiamo che parte metterci. Attori o spettatori? O è una di quelle tragedie in cui il pubblico è parte fondante dello spettacolo ed è responsabile di come va a finire? Siamo da vent’anni in uno strano esperimento di teatro dell’improvvisazione in cui l’unico prezzo da pagare è la vita di qualcun altro?
Vorrei che seguissimo o quantomeno cogliessimo il dignitoso esempio di chi i vent’anni li ricorda ogni giorno, in silenzio.
Le 11.541 sedie rosse vuote che attraverseranno l’arteria principale di Sarajevo nel giorno del 6 aprile 2012.
Le 11.541 persone che hanno lasciato un posto vuoto e che oggi sono in silenzio, ma presenti come non mai.